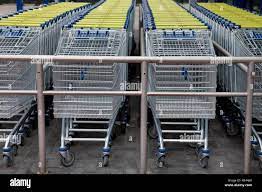L’inflazione è una grande tassa che pesa in particolare sui redditi fissi da lavoro dipendente. Prendiamo un barista e un operaio. A parità di aumento dei prezzi, il barista potrà aumentare le sue entrate alzando il prezzo del caffè, recuperando così, almeno in parte, la crescita dei costi. Per l’operaio è più difficile. Perché i contratti di lavoro si rinnovano se va bene ogni tre anni (ma spesso ci vuole più tempo, tant’è che oggi oltre il 50% dei contratti è scaduto). Da qui l’emergenza salari, contro cui sabato 7 ottobre la Cgil scende in piazza con una manifestazione nazionale.
Il vero indicatore
La vera misura di quanto guadagnano le persone è quello che in economia si chiama salario reale, cioè il salario rapportato ai prezzi. Secondo i dati Ocse, l’Italia è tra le grandi economie il Paese in cui i salari reali sono diminuiti di più dal nell’ultimo anno. Meno 7,3%. Il problema è che piove sul bagnato. Nel senso che i salari reali in Italia, sempre secondo l’Ocse, erano già scesi del 2,9% dal 1990 al 2020. Insomma, l’alta inflazione generata dalla guerra in Ucraina e della veloce ripresa post Covid aggrava un problema che avevamo già. Se fino a questo punto i protagonisti della storia sono due — i salari e i prezzi — per capire che cosa stia succedendo bisogna introdurre un terzo attore: la produttività. La produttività è la quantità di prodotto che si riesce a sfornare nell’unità di tempo. Prendiamo due fabbriche che producono bicchieri identici, di pari qualità. Se nella prima ogni lavoratore ne produce due all’ora e nella seconda tre all’ora è evidente che la seconda realtà è decisamente più produttiva. Avrà bisogno di meno dipendenti per produrre la stessa quantità di bicchieri. Di conseguenza avrà costi più bassi e si potrà permettere anche di pagare retribuzioni più alte.
Anni Novanta: lo spartiacque
Il problema dell’Italia è che la nostra produttività ha smesso di crescere da un pezzo. Precisamente dalla metà degli anni Novanta, e infatti è da allora che le retribuzioni reali hanno smesso anch’esse di crescere. Dal 2000 al 2020, secondo l’Eurostat, in media la produttività in Italia è aumentata dello 0,33% l’anno contro l’1% della Germania e lo 0,94% della Francia. Tutto questo era già un problema prima che arrivasse l’inflazione, ma ora lo è ancora di più. Se crescesse la produttività si potrebbero aumentare le retribuzioni compensando almeno in parte la crescita dei prezzi, e nello stesso tempo non si metterebbe in difficoltà l’economia. Quest’ultima postilla è fondamentale. In realtà i salari potrebbero aumentare anche senza che cresca la produttività. Ma in quel caso si metterebbe in atto una controproducente spirale prezzi-salari. Torniamo al barista dell’esempio precedente: se il suo dipendente pretende un aumento perché il carrello della spesa è cresciuto, allora il barista, a parità di produttività, potrebbe reagire aumentando a suo volta il prezzo del caffè per recuperare quanto ha sborsato in più. Ma se tutti si comporteranno così allora tutti i prezzi aumenteranno. E il dipendente chiederà un secondo aumento. Il solito cane che si morde coda. Se invece aumentasse la produttività, si potrebbero incrementare le buste paga senza bisogno di alzare subito i prezzi. Insomma, senza rivalersi sul consumatore.
La spirale ferma ai box
In realtà nel nostro Paese, nonostante la produttività sia ferma al palo, la temuta spirale prezzi salari non è mai partita. Questo è avvenuto prima di tutto grazie a un sistema di contrattazione pensato e varato nel 1993 anche nell’ottica di stabilizzare i prezzi ed evitare la spirale. Come si diceva all’inizio in Italia i contratti vengono aggiornati se va bene ogni tre anni. E poi la contrattazione si svolge a due livelli: nazionale e aziendale. Ma a livello aziendale la contrattazione è praticata solo dal 26% delle imprese. E poi c’è da dire che, in generale, nei settori dove la produttività è bassa contrattare è più difficile. Il settore chimico produce ricchezza, ha investito, è all’avanguardia, e infatti i contratti si rinnovano appena scaduti e, di solito, con discreti aumenti. Lo stesso si può dire per la metalmeccanica. Ma nei settori a bassa produttività, soprattutto nei servizi, si spuntano aumenti risicati. Basti pensare alla vigilanza dove il contratto nazionale è stato rinnovato di recente e i lavoratori guadagnano 5,37 euro l’ora, ben sotto dei nove euro che l’opposizione vorrebbe come salario minimo.
Un comitato al Cnel
Tutto risolto allora? Non proprio. Se la «tassa» generata dall’inflazione è pagata per la quasi totalità dai lavoratori dipendenti allora è tutto il Paese ad avere un problema. Non bisogna dimenticare che oltre il 60% del nostro prodotto interno lordo è legato dai consumi interni, delle persone che abitano sul nostro territorio. Se il valore reale delle retribuzioni si abbassa così tanto e così velocemente è tutta l’economia che ne risente. E questo è un rischio soprattutto oggi perché la frenata dei consumi interni non può essere compensata da un aumento delle esportazioni visto che la locomotiva tedesca a cui siamo strettamente agganciati sta rallentando e anche l’economia cinese è in stallo. È arrivato il momento di mettere la produttività al centro. Avremmo dovuto farlo prima ma ora non si può più rimandare. Dal 2016, a seguito di una raccomandazione del Consiglio europeo, molti Paesi dell’Unione hanno nominato dei comitati per la produttività. Oggi nell’area Ocse operano una ventina di productivity board. Il Cnel si è candidato per l’Italia a diventare la sede dove elaborare proposte. Potrebbe essere un punto di partenza, purché si faccia sul serio.