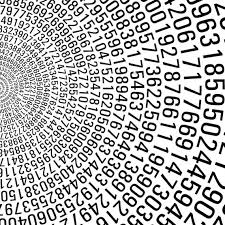Dopotutto c’è da rallegrarsi. Si evade un po’ di meno. La digitalizzazione dell’economia rende qualsiasi attività economica, almeno in teoria, tracciabile. E se dovessimo, solo per un attimo, immaginare l’applicazione dell’intelligenza artificiale, del riconoscimento facciale — oltre alla piena disponibilità a incrociare, privacy permettendo, anagrafi e banche dati — la conclusione non potrebbe che essere una sola: il futuro sarà a evasione zero. Ma nessuno può ragionevolmente augurarsi uno scenario di questo tipo, distopico e dittatoriale. Una sorta di Grande Fratello che tutto spia e tutto sa. La lotta all’evasione fiscale non è solo una questione tecnologica, ma soprattutto civica, culturale. Un tema di giustizia e responsabilità individuale e collettiva. La misura più autentica del fatto che esista una società di destino, consapevole della propria dimensione storica, dei doveri di solidarietà e partecipazione. La cittadinanza attiva e responsabile è un fattore insostituibile di crescita (non solo economica). Ridotta a una dimensione solo passiva (l’idea di sentirsi sempre e comunque in credito con il resto della società) apre una crepa destinata ad allargarsi in un baratro.
Il recente aggiornamento, con i dati relativi al 2021, della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, registra un discreto miglioramento. Le mancate entrate tributarie sono state stimate nell’anno in 73,2 miliardi; quelle contributive in 10,4. La somma fa 83,6 miliardi, il 3,1 per cento in meno rispetto al 2020. Ancora tanto, tantissimo. L’insieme di tre manovre di bilancio. Ma il cosiddetto tax gap — ovvero la differenza fra quanto si dovrebbe pagare e quanto in realtà si paga — è sceso dal 21% del periodo 2016-2020 al 15,3% del 2021. Non è poco.
C’è però un aspetto pressoché sconosciuto al dibattito pubblico. Emerge, con connotazioni inquietanti, tra le righe del lavoro della commissione ministeriale presieduta da Alessandro Santoro, ordinario di Scienza delle Finanze all’Università Milano Bicocca. Ed è la fuga dall’Irpef dei contribuenti italiani grazie al cumularsi di regimi forfettari speciali e a provvedimenti favorevoli soprattutto al lavoro autonomo e alle piccole imprese. Con una doppia conseguenza. Primo: diventa più difficile monitorare la propensione all’evasione di questi “transfughi” del Fisco e dunque quel tax gap che si misura è via via meno attendibile. Secondo: l’Irpef è sempre di più la «prigione» nella quale sono intrappolati dipendenti e pensionati, ormai gli unici a sostenere di fatto il peso dell’unica area impositiva nella quale si applica la progressività sancita dalla Costituzione.
I lavoratori dipendenti coprono oltre la metà del gettito dell’imposta; i pensionati un terzo. In generale per ogni contribuente che versa almeno un euro — secondo i calcoli di Itinerari previdenziali — ce ne sono due che non versano nulla. Il 42% dei contribuenti paga il 91% del totale. Il 54% della popolazione ha redditi mediani inferiori a 10 mila euro lordi l’anno. Insomma, un Paese povero, allo stremo.
I «buchi» della tassa
«L’Irpef è ormai come una gigantesca groviera, piena di buchi — è l’immagine cara a Santoro — e se continueremo così non sarà più l’architrave del sistema fiscale, l’imposta personale di tutto il reddito, il caposaldo che assicura principi di equità orizzontale e verticale come dovrebbe avvenire nei Paesi democratici». La fuga dall’Irpef è cominciata subito dopo la sua introduzione, con la riforma del 1974, a valle dei lavori della Commissione Cosciani. Altrove, un’imposta personale e progressiva era già stata adottata da decenni. Lo testimoniano bene, nel loro lavoro dal titolo Le riforme dell’Irpef, uno sguardo attraverso 45 anni di storia, due studiosi come Simone Pellegrino e Paolo M. Panteghini.
La storia delle aliquote
All’inizio, l’aliquota massima era addirittura del 72 per cento oltre i 500 milioni di lire (oggi al 43 per cento). Una curiosità: nel 1978 soltanto 18 contribuenti dichiaravano un reddito superiore al mezzo miliardo di lire. Non vi erano, inizialmente, detrazioni per oneri. L’inflazione produsse, però pesanti distorsioni che resero necessari diversi interventi. Ma dall’Irpef cominciarono ad essere sfilati alcuni redditi, come quelli da capitale. E cominciò la lunga e ininterrotta stagione del Fisco à la carte, dei regimi speciali, l’agricoltura per esempio, dei trattamenti a favore di alcune categorie o semplicemente constituency elettorali. Al pari di ciò che è avvenuto sul versante previdenziale. Anche per semplificare una macchina fiscale diventata mastodontica, inefficiente e, in certi casi, oppressiva.
La globalizzazione ha liberato il movimento dei capitali, meno quello di altri fattori. E ha favorito l’ingrossarsi di un fenomeno che ha caratterizzato l’intero dopoguerra italiano, ovvero l’esportazione di capitali per sottrarsi al Fisco e difendersi dalla svalutazione della lira. Si stima che ancora oggi — nonostante la svolta americana e del G20 che ha decretato la sostanziale fine per esempio del segreto bancario svizzero e il Common reporting standard sullo scambio automatico di informazioni — vi siano almeno 200 miliardi di dollari di proprietà italiana nei paradisi fiscali, il 10% di tutta la ricchezza mondiale off-shore.