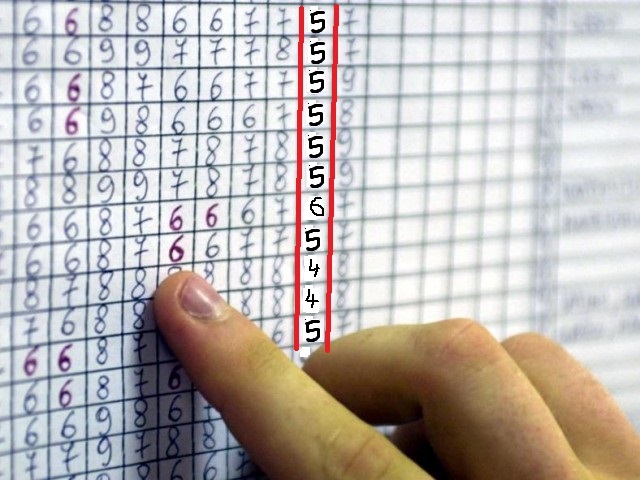(Due parole, d’estate, ed scuola, di s. stefanel, dirigente Liceo scientifico, udine)
L’estate porta sempre con sé il dibattito sui risultati Invalsi e sugli esiti degli esami di stato facendo emergere l’inesistente cultura della valutazione italiana propria dell’opinione pubblica e di troppe componenti della scuola. Inoltre l’estate fa emergere anche la stucchevole polemiche sulle competenze, sui voti alti, sulla scuola figlia e vittima del sessantotto. Il tutto visionato da un punto di vista solo liceale, con commentatori che boccerebbero tutti gli studenti che non scelgono di studiare a fondo greco e latino. Poiché, però, l’indignazione non serve a nulla provo qui con “due parole”, ammesso che queste, invece, possano servire in una società e in un mondo che brucia tutto con la velocità di Instagram.
Con grande voluttà e gran spregio del senso del ridicolo vengono messe in estate in correlazione alcune considerazioni che nascono da contesti diversi:
– i dati Invalsi fotografano un sud in ritardo rispetto al nord e mostrano i dati Invalsi in linea con le rilevazioni Ocse-Pisa;
– all’esame finale del secondo ciclo (che qualcuno ancora si ostina a chiamare “maturità” anche se con la maturità delle persone con c’entra nulla) non viene bocciato nessuno o quasi;
– al sud fioccano 100 e 100 e lode in controtendenza rispetto ai risultati Invalsi.
Alcuni colleghi dirigenti del nord (con una certa malcelata tendenza allo sciacallaggio) si buttano estivamente sui dati per rimarcare la serietà delle scuole del nord di fronte alla leggerezza di quelle del sud. Le scuole del sud, per lo più compostamente, si sottraggono a questo dibattito estivo e poi tutto torna come prima.
Dal punto di vista scientifico (che non interessa praticamente a nessuno) la commistione di questi dati è assurda: al sud ci sono molti studenti molto bravi che giustamente sono licenziati con voti molti alti. Cosa c’entra tutto questo coi dati Invalsi negativi per il sud? I 100 e 100 e lode mica vengono assegnati agli studenti deboli o debolissimi: quelli al massimo escono dall’esame di stato con 60 o 61, al nord come al sud. La cosa, inoltre, che fa inorridire è che l’argomento è “brandito” da commentatori per lo più in pensione che conoscono la scuola italiana perché sessant’anni fa l’hanno frequentata, o da dirigenti che di solito guidano licei del nord di prestigio frequentati dai migliori studenti in circolazione. Questa caotica sovrapposizione di dati, che non c’entrano tra loro, viene poi trasformata in autorevoli opinioni e tutto non può che fermarsi lì.
Se proprio vogliamo incrociare i due dati sarebbe interessante sapere quanti studenti sia al nord che al sud con valutazioni basse nell’Invalsi hanno preso 100 o 100 e lode all’esame di stato. Non conosco questi dati ma propendo per lo zero per cento o poco più. Se ho ragione allora chiedo di cosa si parla? Confrontare i dati deboli di un sistema scolastico con gli esiti dei migliori studenti dello stesso sistema è segno di una grande incompetenza valutativa, ma anche di smemoratezze assolute: a cominciare da quella basilare che ci fa individuare sempre e dovunque e facilmente il “migliore della classe”. Se una classe è debole al migliore diamo voti bassi o quelli che si merita? L’esame di stato è dentro la stessa logica: se uno è bravo deve avere il voto alto anche se il contesto in cui studia è modesto.
Decisamente autolesionista è poi la manifestata voluttà con cui molti esprimono il desiderio che all’esame di stato ci siano bocciati. Gli stessi, però, non desidererebbero mai che ci fossero bocciati alle tesi di laurea, perché la fine di un percorso lungo deve essere accompagnata, non messa davanti ad una prova concorsuale. Anche perché abbiamo la dispersione scolastica (leggi soprattutto bocciature) più alta d’Europa. Magari qualche bocciato in più potrebbe esserci, invece, nei concorsi a cattedra, dove partecipano solo i laureati e dove molti commissari sono professori universitari. Ma questo è un altro discorso.
C’è poi, sempre attiva ma d’estate un po’ di più, la critica al lassismo, ai voti alti, alle competenze da eliminare a favore delle vecchie e amate conoscenze, alla lotta contro le “non cognitive skills”, anche se tutte le aziende e tutta la società della conoscenza quelle cercano dentro un sistema ordinato di “cognitive skills” (che molto spesso sono trascurate proprio dalle università da cui vengono i commentatori più appassionati del sapere trasmissivo, cartaceo, statico).
Le competenze sono nient’altro che il saper utilizzare conoscenze e abilità in ogni contesto e non solo in quello scolastico. Una competenza si poggia sempre su conoscenze e non esiste mai in senso generico. Non si può però valutare una competenza con compiti e interrogazioni standard, perché la sua valutazione è più complessa. Questa idea del “docente trasmettitore” che imbonisce le piccole folle a lui assegnate come un muezzin, forte di una cultura tradizionale, statica e ben definita è alla base della disastrosa situazione italiana (non solo scolastica) dove tutti vogliono parlare e nessuno vuole ascoltare. Abbiamo tanti conferenzieri e pochi pedagogisti, abbiamo tanti che proclamano e declamano e molti di meno che sanno insegnare. Quando poi si valuta tutto cade nel grigio in cui ogni colore si confonde: si valuta, di solito, attraverso misurazioni standard (compiti e interrogazioni) autodefinite dal docente che poi misura decidendo la scala numerica e che e trasforma i voti attraverso le medie in valutazioni. Percorso completamente sbagliato che limita la conoscenza dei progressi dei migliori, ripete all’infinito le performance dei medi e affossa quelli in difficoltà, che con questi metodi di valutazione sono nella stessa situazione di chi, non sapendo nuotare, viene gettato in acqua con addosso uno zaino di sassi.
Circola poi anche la “malsana” idea che per gli studenti in difficoltà sia necessario far più scuola e non migliorare gli strumenti pedagogici e selezionare i saperi da insegnare, come se il soggetto più debole potesse essere aiutato dall’aumento di carico (quando ero alpino se un mulo era “debole” si diminuiva il suo carico, non lo si aumentava: così, per dire). In questo ci mette del suo anche l’Invalsi che misura i ritardi in periodi (“in certe zone del paese si è indietro di un anno”, ecc.), senza mai curarsi del problema principale, che non è quanto si sta a scuola, ma come si sta a scuola, che non è quanto si studia ma come si studia. Parole al vento, lo so, legate all’altro grande equivoco su cui nessuno vuole mai entrare: i docenti con le loro metodologie ottengono con la gran maggioranza degli studenti risultati sufficienti, buoni o ottimi. Le stesse metodologie con una parte degli studenti producono risultati pessimi. Si assiste però a questa considerazione: se lo studente va bene a scuola è merito del docente, se va male è demerito dello studente. Vecchio vizio italiano: privatizzare i ricavi e socializzare le perdite. Forse sarebbe il caso di capire che le metodologie vincenti per la maggioranza sono spesso quelle che distruggono le potenzialità di apprendimento di una parte di studenti. Quando si parla di personalizzazione nessuno sa bene di cosa si sta parlando e troppi sono legati all’idea della lezione privata. Se però si affacciasse in qualcuno il dubbio per cui è il “mio” metodo che porta sia in alto che in basso, allora forse si comincerebbe a parlare di pedagogia, lasciando perdere l’enfasi sugli errori degli studenti e cominciando seriamente a cercare di correggerli.
Da questo punto di vista va letta la decisione ministeriale di far cadere su molte scuole 500 milioni di euro (con assegnazioni di circa 250.000 euro a scuola), basandosi in modo piuttosto oscuro sui dati Invalsi e sui dati della dispersione. Se alle scuole che hanno “prodotto” dispersione con metodologie didattiche e valutative sbagliate si danno tanti soldi chi dice che non perpetreranno ulteriori errori aumentando e non diminuendo la dispersione? Perché i soldi non sono vincolati ad un controllo tutto esterno degli esiti e delle situazioni di partenza? Perché chi boccia più studenti deve avere più soldi se non ha mai messo in campo alcuna metodologi attiva e verificabile per diminuire le bocciature?
Qui si annida l’idea italiana che le bocciature (dei figli degli altri ovviamente) siano una buona cosa e che chi non studia non debba andare avanti, senza mai chiedersi perché costui non studia e non si impegna, e perché non ascolta rapito le conferenze di conferenzieri che non troverebbero uno spettatore se si mettessero sul mercato. Direi che è ora di finirla con la pedagogia svilita a conferenza trasmessa in diretta e che si debba andare a fondo del problema degli apprendimenti e del problema ancor maggiore della loro valutazione, senza inventarsi soluzioni progettuali che non esistono, ma analizzando studente per studente i motivi dei suoi fallimenti.
Insomma, due parole, d’estate.